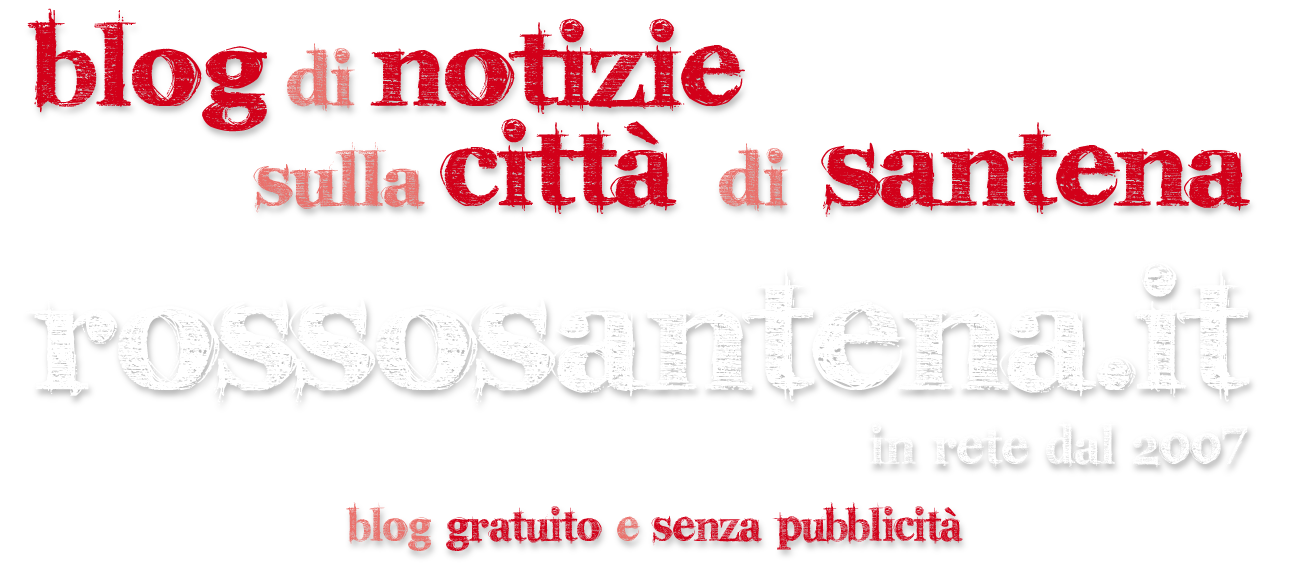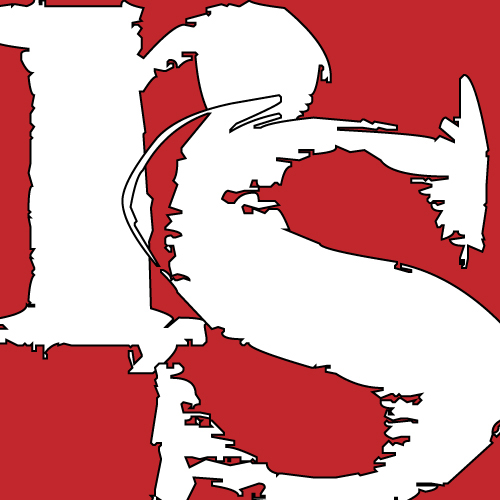SANTENA – 28 novembre 2008 – “Aborto e diritti dell’uomo. A trent’anni dalla legge 194 che ha legalizzato l’aborto e a sessanta dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”: questo il titolo del convegno organizzato dal Centro aiuto alla vita di Santena in collaborazione con il Centroservizi per il volontariato sviluppo e solidarietà in Piemonte, il Comitato verità e vita, il Comune di Santena e l’Unità pastorale 39 della diocesi di Torino che riunisce Santena, Favari, Marocchi, Poirino, Cambiano, Villastellone e La Longa. Il convegno si è svolto venerdì 28 novembre, con inizio alle 20.45, nella sala comunale Visconti Venosta, a Santena. Di seguito la relazione presentata da don Mauro Grosso.

ABORTO E DIRITTI UMANI
Contributo biblico teologico
di don Mauro Grosso
1. Fondazione biblica
Di specifico la Bibbia sull’aborto non offre nulla. Questo non ci stupisce, giacché la rivelazione di Dio agli uomini non comprende, ovviamente, la casistica dettagliata di ogni comportamento. La Bibbia contiene la Parola di Dio rivolta agli uomini, non una trattazione completa della morale e dell’etica. Dalla sacra Scrittura però:
-emerge che Dio è autore della vita;
-si comprende come la vita umana sia preziosa, in quanto ispirata e voluta dal Creatore, e da lui ripresa e continuata in modo diverso e compiuto al termine della parabola terrena;
-si evince il comandamento chiaro: «Non uccidere» (Es 20,13; Dt 5,17);
-si evince che la vita è contemporaneamente un dono e una responsabilità;
-si evince una costante attenzione ai piccoli, ai deboli, agli indifesi, in una parola ai poveri che non hanno voce.
Pur non parlando mai di aborto e quindi non presentando condanne dirette e specifiche in proposito, i testi della Scrittura mostrano una tale considerazione dell’essere umano nel grembo materno, da esigere come logica conseguenza che anche ad esso si estenda il comandamento di Dio di non uccidere. Ecco alcuni testi:
-«Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno» (Sal 71,6);
-«Ascoltatemi, casa di Giacobbe e voi tutti, superstiti della casa di Israele; voi, portati da me fin dal seno materno, sorretti fin dalla nascita» (Is 46,3);
-«Le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto integro in ogni parte; vorresti ora distruggermi? Ricordati che come argilla mi hai plasmato e in polvere mi farai tornare. Non m’hai colato forse come latte e fatto accagliare come cacio? Di pelle e di carne mi hai rivestito, d’ossa e di nervi mi hai intessuto. Vita e benevolenza tu mi hai concesso e la tua premura ha custodito il mio spirito» (Gb 10,8-12);
-«Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio» (Sal 22,10-11);
-«Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro; i miei giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva uno» (Sal 139,13-16);
-«In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore»» (Lc 1,39-45).
La condanna dell’aborto risulta dunque:
-dal comandamento di non uccidere;
-dal concetto espresso di vita umana;
-da una costante attenzione agli “ultimi” (piccoli, deboli, indifesi).
2. Riflessione teologica
Il messaggio cristiano sulla vita è emblematicamente sintetizzato nelle parole di Gesù: «Sono venuto perché abbiano la vita» (Gv 10,10). Da qui sorge la domanda decisiva: perché la vita è un bene? Perché la vita è sempre un bene? La risposta non è principalmente: “Perché siamo figli di Dio”, ma, soprattutto: “Perché il Padre chiama ogni uomo, nel Figlio suo, a partecipare alla pienezza della vita divina, diventando «figli nel Figlio»”. La dignità sublime della vita umana risalta più che dalla luce della sua origine, da quella del suo fine.
A) Il luogo per la migliore esperienza del valore della vita
Qual è il luogo, la situazione che porta a fare la migliore esperienza del valore della vita? Qual è la strada, percorrendo la quale, lo si incontra più sicuramente? Paradossalmente è proprio la precarietà. È questa la via seguita dalla Rivelazione sia nell’Antico Testamento (AT), che nel Nuovo Testamento (NT): «Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato» (Es 15,2).
Per quel che riguarda l’AT, lo documentano l’esperienza dell’Esodo e la riflessione sapienziale, entrambe maturate in una situazione di sofferta precarietà, più materiale nel caso dell’Esodo, più esistenziale-spirituale nel caso della letteratura sapienziale.
Per quanto riguarda il NT, è l’azione stessa di Gesù che lo documenta: tutta la vita di Gesù è un peregrinare nelle contraddizioni e nella stessa perdita della vita. Però proprio in questa situazione Gesù è guidato dalla certezza che la sua vita è nelle mani del Padre; ed è nella sua morte che Gesù rivela tutta la grandezza e il valore della vita umana da lui assunta e resa luogo nel quale la salvezza si attua per tutta l’umanità.
B) Il contenuto del valore della vita
Ma qual è il contenuto del valore della vita, sia in generale, sia per quanto riguarda la vita in condizioni di particolare fragilità?
Per quanto riguarda il valore della vita in generale, è il contesto della creazione e della redenzione a metterlo in evidenza. (a) Nel contesto della creazione, (a1) la vita dell’uomo è caratterizzata da un legame particolare con il Creatore, evidenziato soprattutto dal fatto che solo la sua creazione è presentata come frutto di una speciale decisione da parte di Dio; (a2) il senso del legame è chiarito dal dominio dell’uomo sul mondo e dalle facoltà spirituali più proprie dell’uomo, come la ragione, e la volontà libera; (a3) la conclusione che se ne trae è che la vita che Dio dona all’uomo è tensione verso una pienezza di vita oltre i limiti stessi del tempo. La gloria di Dio risplende sul volto dell’uomo. (b) Mediante la redenzione, nella vita dell’uomo, l’immagine di Dio deturpata dal peccato torna a risplendere e si manifesta in tutta la sua pienezza con la venuta nella carne umana del Figlio di Dio, l’immagine perfetta del Padre (cfr. Col 1,15; Eb 1,3). Il progetto di vita consegnato al primo Adamo trova finalmente in Cristo il suo compimento. Così giunge al suo culmine la verità cristiana sulla vita, la cui dignità è legata non solo alle sue origini, al suo venire da Dio, ma anche al suo fine, al suo destino di comunione con Dio nella conoscenza e nell’amore di lui.
Il valore della vita viene proclamato con un’enfasi tutta particolare, quando la vita si trova in situazioni di particolare precarietà: la fase prenatale, la fase della vecchiaia e della sofferenza. Anche la sola possibilità di offendere, aggredire o addirittura negare la vita in queste condizioni esula dall’orizzonte religioso e culturale del popolo di Dio.
C) Dal valore della vita alla sua sacralità e inviolabilità
La proclamazione del valore della vita ha come conseguenza l’affermazione della sacralità e inviolabilità della vita umana.
La vita dell’uomo è sacra, perché proviene da Dio, è suo dono. Di questa vita, pertanto, Dio è l’unico signore: l’uomo non può disporne (Gen 9,5-6); la vita e la morte dell’uomo sono nelle mani di Dio (cfr. Gb 12,10; 1Sam 2,6; Dt 32,39). Ma questo potere Dio lo esercita non come arbitrio minaccioso, bensì come cura e sollecitudine amorosa nei riguardi delle sue creature (cfr. Sal 131,2; Is 49,15; 66,12-13; Os 11,4).
Dalla sacralità della vita, scaturisce la sua inviolabilità: essa è iscritta fin dalle origini nel cuore dell’uomo. Il comandamento relativo all’inviolabilità della vita umana risuona al centro delle “dieci parole” nell’Alleanza del Sinai (Es 34,28). Il comandamento del “non uccidere”, incluso e approfondito in quello positivo dell’amore del prossimo, viene ribadito in tutta la sua validità da Gesù (Mt 19,16-19).
Questa inscrizione dell’inviolabilità della vita nel cuore dell’uomo è riconosciuta dalla stessa Dichiarazione universale dei diritti umani (1948; art. 3). È una “verità pratica” circa la quale si conviene, indipendentemente dalla giustificazione che se ne fornisce (religiosa, filosofica…) – come ha espresso Jacques Maritain, filosofo francese (1882-1973) che redasse l’introduzione ai lavori per l’elaborazione della Dichiarazione.
3. Deduzione morale
Oggi, nella coscienza di molti, la percezione della gravità dell’aborto è andata progressivamente oscurandosi. Ciò è documentato dal linguaggio, che chiama l’aborto “interruzione di gravidanza”. Questo fenomeno linguistico è segno di un mutamento e crisi del senso morale e sintomo di un disagio delle coscienze.
L’aborto procurato è di fatto l’uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita. Fra tutti i delitti che l’uomo può compiere contro la vita, l’aborto procurato presenta caratteristiche che lo rendono particolarmente grave e deprecabile, se si tiene conto che:
-l’ucciso: siamo al massimo possibile di “innocenza”, di debolezza inerme, di incapacità di difesa;
-la vita che viene stroncata: è una missione divina, a cui viene impedito anche solo di iniziare;
-il responsabile principale dell’uccisione: la madre, cioè la persona che ha con il concepito il legame più profondo e più intimo umanamente immaginabile, la quale talvolta in prima persona decide e chiede l’aborto, senza considerare che nessuna ragione, per quanto grave e drammatica, può mai giustificare la soppressione deliberata di un essere umano innocente;
-l’esecutore principale e i suoi collaboratori, che di solito sono persone che hanno scelto pubblicamente come professione la difesa della vita dei propri simili, quando è minacciata da qualche malattia.
Tutti i moralisti moderni sono d’accordo nel dire che una soppressione di vita – sia pure non ancora “umanizzata”, qualora si abbracciasse una qualche teoria secondo cui si ha l’essere umano solo da un certo punto della gestazione in poi, o addirittura dopo il parto – è un vero delitto, che rientra nella malizia dell’omicidio, se si vuole anticipato o attenuato, in quanto distrugge (nell’ipotesi della “umanizzazione” successiva) un essere che ha tutto per diventare quanto prima uomo, col sopraggiungere della pienezza della sua umanità.
Il fatto della presenza o assenza dell’anima umana nell’embrione, non cambia l’immoralità dell’attacco contro di lui; cambia solo la qualità dell’immoralità: se l’anima è presente, è omicidio; se no, è un attacco immorale alla radice della vita umana. In ogni caso, essendo questione di vita umana, anche il solo esporsi al rischio che l’intervento abortista costituisca soppressione di vita umana, rende già moralmente connotato in negativo l’atto stesso.
4. Applicazione particolare
Una legge a favore dell’aborto riconosce, alla madre che lo vuole, il “diritto” di sopprimere la creatura che ha concepito e mette le strutture e il personale sanitario a disposizione, perché si possa attuare tale proposito senza rischi per la salute e senza alcuna spesa. Una tale tutela giuridica dell’aborto certo si pone in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti umani e i suoi successivi sviluppi, tra cui la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (20/11/1959), secondo cui il fanciullo ha bisogno di una protezione appropriata tanto prima della nascita che dopo.
Nel caso italiano, la legalità giuridica dell’aborto è garantita, com’è noto, dalla Legge 194 del 22/5/1978. Alla luce delle riflessioni sinora condotte sul senso della vita e l’aborto, nei confronti di una legge abortista il cristiano può proporsi:
-l’obiezione di coscienza, da parte del personale medico che opera in reparti in cui possono presentarsi richieste di aborto e da parte dei paramedici in generale, in quanto a questi ultimi può essere richiesto di intervenire a vario titolo in qualsiasi operazione, compresa quella di aborto;
-la valorizzazione degli aspetti positivi della legge, in particolare degli artt. 1° e 2°, che non a caso sono in tale posizione, ma che risultano i più puntualmente disattesi e disconosciuti, sia sul piano attuativo, sia su quello del dibattito pubblico:
-art. 1°: «Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite». Si nota come la legge stessa non riconosce l’aborto come mezzo ordinario, da assumere a cuor leggero, per porre rimedio a gravidanze per così (mal) dire “indesiderate”.
-art. 2°: «I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo all’ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori». Si nota come la legge stessa inviti ad aiutare le donne che chiedono di abortire a trovare vie alternative a questa scelta.
-l’impegno per il superamento della legge stessa, abrogandola e sostituendola con una legge veramente rispettosa della vita e della maternità. Per giungere a modificare la legge occorre però modificare il costume e avviare una seria politica familiare. L’iter può essere lungo e implica necessariamente una condivisione di fini, un convergere di volontà, un ancoramento su principî e non soltanto un accordo fra le parti.
In tutto questo, compito della comunità cristiana è di operare perché cambi radicalmente tutto un insieme di idee, pregiudizi, disposizioni mentali.
(a) È necessario un nuovo stile di vita, caratterizzato soprattutto da due atteggiamenti: eliminare la voracità egoistica di possedere sempre più cose; offrire uno stile caratterizzato dall’accoglienza dell’altro sincera, cordiale, generosa, operosa.
(b) Bisogna perseguire la promozione e difesa di una sessualità degna dell’uomo, attraverso: l’impegno di castità, serena e gioiosamente vissuta da giovani, fidanzati, sposi; il contrastare la sistematica azione dissolutrice che viene dalla pornografia; il contrastare la diffusa mentalità antinatalista e il modello culturale dominante della coppia con uno o due figli soltanto.
(c) Si tratta di intessere una rete di solidarietà operosa per le famiglie in difficoltà: impegnarsi attivamente per tutto quanto può aiutare le famiglie, le madri, i bambini; cambiare atteggiamento nei confronti dei figli portatori di handicap, e verso le famiglie che ne hanno.
(d) Infine, è importante sviluppare la mentalità del donarsi, a partire dal volontariato, per mezzo della cui gratuità, non saltuaria, ma abituale, si può colpire al cuore la mentalità abortista, aiutando a riscoprire che la vita è innanzitutto dono gratuito.
Questi e altri spunti manifestano le sfide che la comunità cristiana può e deve affrontare per far crescere il rispetto della vita secondo quanto inscritto nel cuore di tutti gli uomini e compiutamente rivelato da Dio stesso.
Santena, 28 novembre 2008
d.mauro.grosso@gmail.com