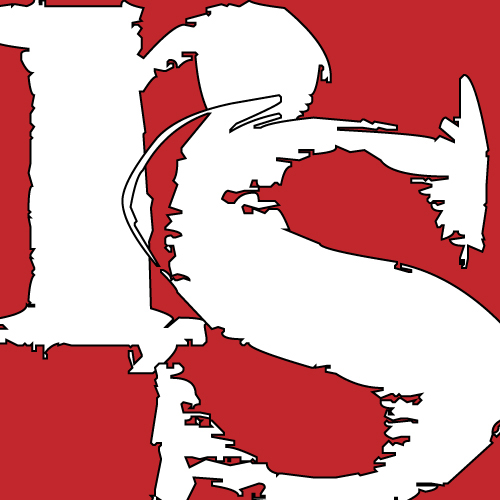01 febbraio 2009
Riflessione di Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, sulla pazienza.
Pazienza
La Scrittura attesta che la «pazienza» è anzitutto una prerogativa divina: secondo Esodo 34,6 Dio è makróthymos, «longanime», «magnanime», «paziente» (in ebraico l’espressione equivalente suona letteralmente: «lento all’ira»).
Il Dio legato in alleanza al popolo dalla «dura cervice» non può che essere costitutivamente paziente. Questa pazienza è stata manifestata compiutamente nell’invio del Figlio Gesù Cristo e nella sua morte per i peccatori, ed è ancora ciò che regge il tempo presente: «Il Signore non ritarda nell’adempire la promessa, ma usa pazienza (makrothumeî) verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti giungano a conversione» (2 Lettera di Pietro 3,9). La pazienza del Dio biblico si esprime al meglio nel fatto che Egli è il Dio che parla: parlando, dona il tempo all’uomo per una risposta, e quindi attende che questi arrivi alla conversione.
La pazienza di Dio non va confusa con l’impassibilità di Dio, anzi, essa è il «lungo respiro della sua passione» (E. Jüngel), è la lungimiranza del suo amore, un amore che «non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva» (Ezechiele 33,11), ed è una forza operante anche quando il movimento di conversione non è ancora compiuto.
La pazienza di Dio trova così la sua espressione più pregnante nella passione e croce di Cristo: lì la dissimmetria fra il Dio che pazienta e l’umanità peccatrice si amplia a dismisura nella passione di amore e di sofferenza di Dio nel Figlio Gesù Cristo crocifisso. Da allora la pazienza, come virtù cristiana, è un dono dello Spirito (Galati 5,22) elargito dal Crocifisso–Risorto, e si configura come partecipazione alle energie che provengono dall’evento pasquale.
Per il cristiano la pazienza è dunque coestensiva alla fede: ed è sia perseveranza, cioè fede che dura nel tempo, che makrothymía, «capacità di guardare e sentire in grande», cioè arte di accogliere e vivere l’incompiutezza. Questo secondo aspetto dice come la pazienza sia necessariamente umile: essa porta l’uomo a riconoscere la propria personale incompiutezza, e diventa pazienza verso se stessi; essa riconosce l’incompiutezza e la fragilità delle relazioni con gli altri, strutturandosi così come pazienza nei confronti degli altri; confessa l’incompiutezza del disegno divino di salvezza, configurandosi come speranza, invocazione e attesa di salvezza. La pazienza è la virtù di una chiesa che attende il Signore, che vive responsabilmente il non-ancora senza anticipare la fine e senza ergere se stessa a fine del disegno di Dio.
Essa rigetta l’impazienza della mistica come dell’ideologia e percorre la via faticosa dell’ascolto, dell’obbedienza e dell’attesa nei confronti degli altri e di Dio per costruire la comunione possibile, storica e limitata, con gli altri e con Dio. La pazienza è attenzione al tempo dell’altro, nella piena coscienza che il tempo lo si vive al plurale, con gli altri, facendone un evento di relazione, di incontro, di amore.
Per questo, forse, oggi, nell’epoca stregata dal fascino del «tempo senza vincoli» – in cui la libertà viene spesso immaginata come l’assenza di legami, di vincoli, come possibilità di operare dei ricominciamenti assoluti dall’oggi al domani, che riportino a un incontaminato punto di partenza, azzerando o rimuovendo tutto ciò in cui prima si viveva, e anzitutto le relazioni e gli impegni assunti – può apparire così fuori luogo, e al tempo stesso così urgente e necessario, il discorso sulla pazienza: sì, per il cristiano, essa è centrale quanto l’agape, quanto il Cristo stesso.
Il pazientare, cioè l’assumere come determinante nella propria esistenza il tempo dell’altro (di Dio e dell’altro uomo), è infatti opera dell’amore. «L’amore pazienta» (makrothymeí), dice Paolo (1 Lettera ai Corinzi 13,4). E la misura e il criterio della pazienza del credente non possono risiedere, in ultima istanza, che nella «pazienza di Cristo» (2 Lettera ai Tessalonicesi 3,5: hypomonè toû Christoû). Ecco perché spesso la pazienza è stata definita dai Padri della chiesa come la summa virtus (cf. Tertulliano, De patientia I,7): essa è essenziale alla fede, alla speranza e alla carità.
Ha scritto Cipriano di Cartagine: «Il fatto di essere cristiani è opera della fede e della speranza, ma perché la fede e la speranza possano giungere a produrre frutti, abbisognano della pazienza» (Cipriano, De bono patientiae 13). Innestata nella fede in Cristo, la pazienza diviene «forza nei confronti di se stessi» (Tommaso d’Aquino), capacità di non disperare, di non lascairsi abbattere nelle tribolazioni e nelle difficoltà, diviene perseveranza, capacità di rimanere e durare nel tempo senza snaturare la propria verità, e diviene anche capacità di sup-portare gli altri, di sostenere gli altri e la loro storia. Nulla di eroico in questa operazione spirituale, ma solo la fede di essere a propria volta sostenuti dalla braccia del Cristo stese sulla croce.
In questa difficile opera il credente è sorretto da una promessa: «Chi persevera fino alla fine sarà salvato» (Matteo 10,22; 24,13). Promessa che non va intesa semplicemente come un rimanere saldi in una professione di fede, ma come un mettere in pratica la pazienza e l’attiva sopportazione tanto nei rapporti intra-ecclesiali, intra-comunitari («sopportatevi a vicenda»: Colossesi 3,13), quanto nei rapporti della comunità cristiana ad extra, con tutti gli altri uomini («siate pazienti con tutti»: 1 Lettera ai Tessalonicesi 5,14). La pazienza diviene così una categoria che interpella la struttura interna della comunità cristiana e il suo assetto nel mondo, in mezzo agli altri uomini, ai non-credenti. E mentre interpella, inquieta!
Enzo Bianchi
Le parole della spiritualità