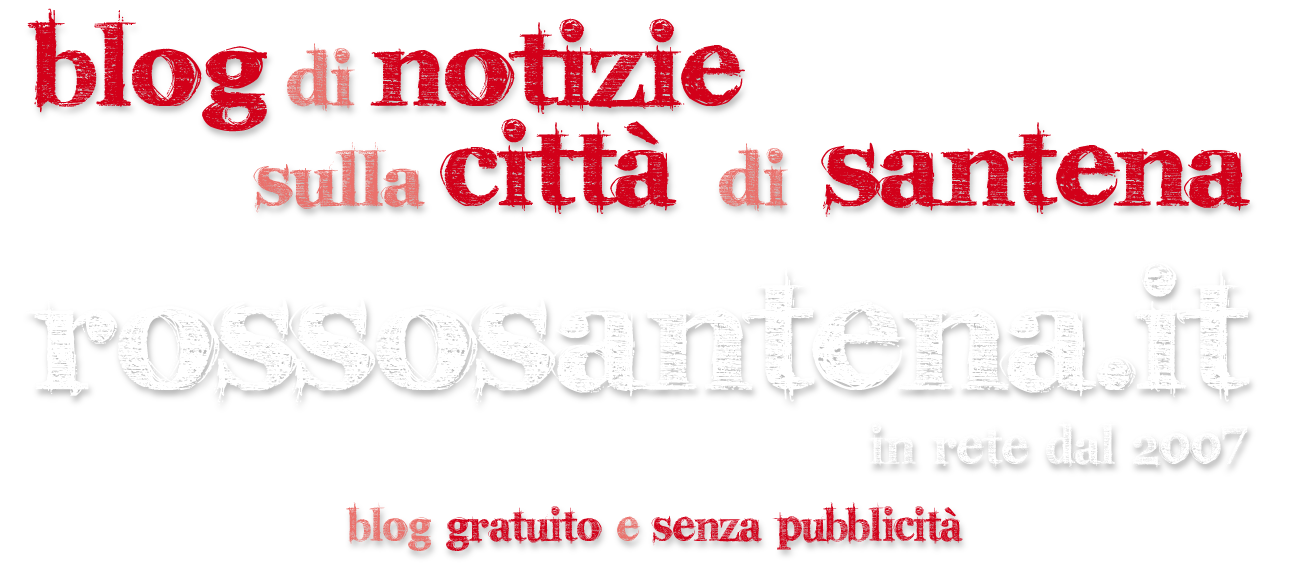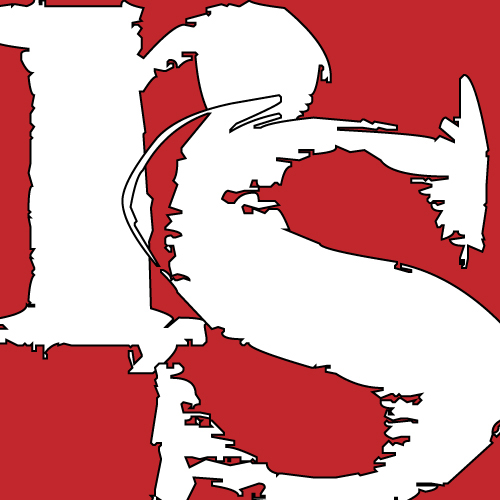SANTENA – 30 giugno 2024 – Una primavera-estate così sì è vista nel 1816. Poi nell’autunno-inverno e primavera del 1817 fu ancora peggio. Come oggi – dopo due anni di siccità 2022/23 e uno di piogge 2024 – la situazione era alquanto incerta. Cambiava il clima e nasceva lo Stato sociale.

Camillo Cavour (1810-1861) allora era un bambino che si formava in una moderna famiglia di imprenditori agricoli. I Benso con Michele, il padre di Camillo, stavano allargando gli orizzonti dei loro investimenti. Oltre ai possedimenti nel Bacino Idrografico del fiume Banna e in quel di Cavour nel Pinerolese, la famiglia aveva nel Monferrato, affacciata sulla valle del Tanaro, la tenuta di Bellangero, in quel di Isola d’Asti. Dal 1806 grazie alla zia Vittoria de Sellon avevano anche acquisito 479 giornate a Grinzane, nelle Langhe, vicino ad Alba, dove si produceva vino. Adesso puntavano l’attenzione sul Principato di Lucedio, nel vercellese, che il proprietario Camillo Borghese, cognato dello sconfitto Napoleone, doveva vendere. Là c’era la Tenuta di Leri dove si coltivavano i risi. L’impresa era rischiosa. Il momento era delicato e non solo per le questioni climatiche. I Benso, compromessi con i Francesi, dopo la caduta di Napoleone cercavano di rientrare alla corte dei Savoia. Un grande aiuto venne dai Marchesi di Barolo e soprattutto dagli Alfieri di Sostegno. L’Italia stava cambiando. Nel 1815 a Castelnuovo era nato San Giovanni Bosco, mentre nello stesso anno il congresso di Vienna aveva annesso la Repubblica di Genova al Regno di Sardegna. La Restaurazione, sospinta dai cambiamenti politici, geografici e sociali, confermava che non era possibile fermare il progresso sostenuto dalle tecnologie, dalle scienze e dalla domanda di cibo.
Nell’aprile del 1815 avvenne il grande sconvolgimento del clima globale. Il vulcano Tambora, dell’Isola di Sumbawa, arcipelago delle Sonda, scaraventò nell’atmosfera un’immensa nube di cenere. Nella primavera ed estate del 1816 il clima in Europa si raffreddò massacrando tutti i raccolti. Nel Bacino del Banna e in Piemonte i poveri morivano di fame. Allora si viveva alla giornata. La vita delle persone e degli animali era legata all’andamento delle stagioni. Le scorte di alimenti per le famiglie misere, passato l’inverno, erano esaurite. I Benso erano sul chi vive, da due anni i raccolti erano magri. Anche a Santena venne a mancare il cibo. Con l’arrivo della bella stagione si sperava nelle erbe, latticini, ortaggi e frutti primaverili, in attesa dei cereali raccolti tra fine giugno e luglio. Ma la primavera e l’estate del 1816 furono senza sole, tanta pioggia e nevicò perfino nel mese di luglio. Nessuno conosceva la causa di un fenomeno che giorno per giorno si ingigantiva. Si credeva a una punizione divina, cui si cercava di rimediare con le preghiere e le processioni. Ma il peggio doveva ancora venire. In autunno, in inverno e fino al maggio 1817, tranne una piccola nevicata il 17 gennaio, non cadde acqua. Persino la rugiada era sparita. Le bestie morivano. Le semine erano in pericolo. L’orzo, il grano e il mais ingiallivano nei campi. Le mamme non avevano il latte. Morivano i bambini e i vecchi, poi toccò agli adulti. I furti in campagna aumentavano. Di giorno in giorno cresceva il numero di mendicanti. Quando non ci fu più niente da rubare, non restò che la disperazione. Le autorità civili insieme a quelle religiose dovettero intervenire distribuendo cibo ai poveri. Nel Chierese e nel Regno di Sardegna fioriva l’idea dello Stato sociale per nutrire le persone. Michele Benso era in prima linea insieme al Priore di Santena don Giuseppe Pezzana (1765-1838), alla cui memoria è intestata la via in cui c’è la macelleria di Secondino Crivello. Poi finalmente il 24-25 maggio 1817 arrivò la pioggia e con essa la ripresa alimentare. Il maltempo era durato due annate agricole. Nei registri parrocchiali delle morti resta la traccia lasciata dai picchi di decessi del biennio infernale.
Della vicenda parla Carlo Smeriglio in “Santena: da villaggio a città”, pag. 230, dove ricorda l’intervento del Consiglio Comunale di Chieri, per la distribuzione giornaliera di minestra e per la realizzazione di lavori pubblici fatti per dare lavoro e reddito. Una visione keynesiana ante litteram cui contribuì anche Michele Benso, facendo eseguire lavori nel Castello, nel Parco e abbattendo vecchie case per realizzare la nuova piazza al fianco della Chiesa parrocchiale. Miracolosa fu quella minestra dei poveri. Un salvavita, rimasto nelle memorie dei Santenesi.
Gino Anchisi,
da Santena la città di Camillo Cavour, 30 giugno 2024